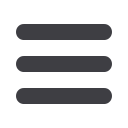

376
SIMULAZIONI D’ESAME
TEST CISIA
www.
edises
.it
ducia nel progresso, soprattutto nella
tecnologia e nella medicina, proseguì
dal periodo d’oro del V secolo fino al IV
secolo a.C.; analogamente, una simile fi-
ducia nel progresso e in particolare nel-
la tecnologia e nella medicina si ritrova
a partire dal XIX secolo fino ad oggi.
Non ci fu tuttavia “alcuna diminuzione
dell’energia creativa”: fu l’epoca dei più
grandi oratori e filosofi, si svilupparono
nuove forme di arte e letteratura, furo-
no compiuti importanti progressi in ma-
tematica e in astronomia. Ma, come nel
nostro caso, “almeno qualcosa dell’anti-
ca fiducia era andato perduto”.
Oggigiorno il progresso scientifico e
tecnologico prosegue senza sosta e l’e-
splorazione dello spazio ha condotto a
straordinarie scoperte astronomiche. La
creatività che ha dato vita a nuove forme
di cultura – i romanzi di fantascienza,
l’impressionismo in arte e in letteratura,
i risultati raggiunti dal cinema, dalla ra-
dio e dalla televisione – continua: siamo
molto lontani dalla sterilità culturale
che regnava a Roma nel IV secolo d.C.
Ciò che, invece, minaccia questo svilup-
po culturale e che più assomiglia alla
situazione dell’antica Roma è l’archi-
tettura contemporanea. Nel III secolo
l’ordine classico si era dissolto in pareti
spoglie e facciate nude, allo stesso modo
in cui le nostre abitazioni in vetro e ce-
mento hanno preso il posto degli edifici
del XIX e dell’inizio del XX secolo, così
variegati nello stile e nelle decorazioni.
In scultura, Thorwaldsen, Gibson e
Bates, uniti al fascino spensierato di
Carpeaux, segnano il tramonto di una
lunga tradizione, sebbene alcuni ele-
menti di essa permangono nelle forme
voluminose di Maillol e Henry Moore.
Con Rodin qualcosa di nuovo è compar-
so: il suo “Balzac” riflette lo spirito e la
personalità del soggetto per mezzo di
effetti di chiaroscuro, illusioni ottiche
che si sostituiscono a forme ben deline-
ate, oppure nell’argilla modellata per
dare corpo alle sue figure umane dotate
di una plasticità che permane nella co-
lata di bronzo e persino nella copia di
marmo. Questo stile ricorda la scultura
impressionista del III secolo ed è pro-
seguito con molti esperimenti moderni
di natura più o meno astratta. A questo
proposito poi il ruolo giocato dal dise-
gno astratto può essere equiparato alla
varietà di motivi non-figurativi del post-
classicismo e del periodo bizantino, più
tardi intensificato dall’iconoclastia e
dall’influenza dell’Islam. Le tendenze
eterogenee e anarchiche dell’arte con-
temporanea sono espressione dell’an-
goscia dei tempi moderni – ciò si vede
maggiormente negli stili pittorici che
rompono con la forma classica, fino alla
successiva corrente artistica rappresen-
tata da Picasso, dal naturalismo all’a-
strattismo e al simbolismo.
L’imminente angoscia dell’epoca è
espressa, nel XIX secolo, da artisti come
Van Gogh, in particolare nei suoi autori-
tratti, nei suoi paesaggi tormentati e an-
gosciosi e nell’“Urlo” di Munch del 1893.
Quasi un secolo prima Goya dipinse il
suo “3 maggio 1808”. Nei “Disastri della
guerra” e nelle “Pitture nere” dell’ultima
fase della sua vita egli presenta la guer-
ra e ogni sorta di malvagità in un modo
completamente diverso dal classicismo
accademico. Un altro secolo dovette tra-
scorrere prima che il crudele spreco e
la mutilazione di giovani vite giungesse
alla coscienza pubblica nei terribili anni
che seguirono le entusiasmanti aspet-
tative dell’agosto 1914. Goya, tuttavia,
aveva già ritratto gli effetti della guerra
negando l’umanità tra corpi in decom-
posizione, donne stuprate e i gemiti dei
loro figli. La sete di sangue, il male sa-
dico è rappresentato nelle “Follie” – in
esse non vi è spazio per il riso – e nei


















