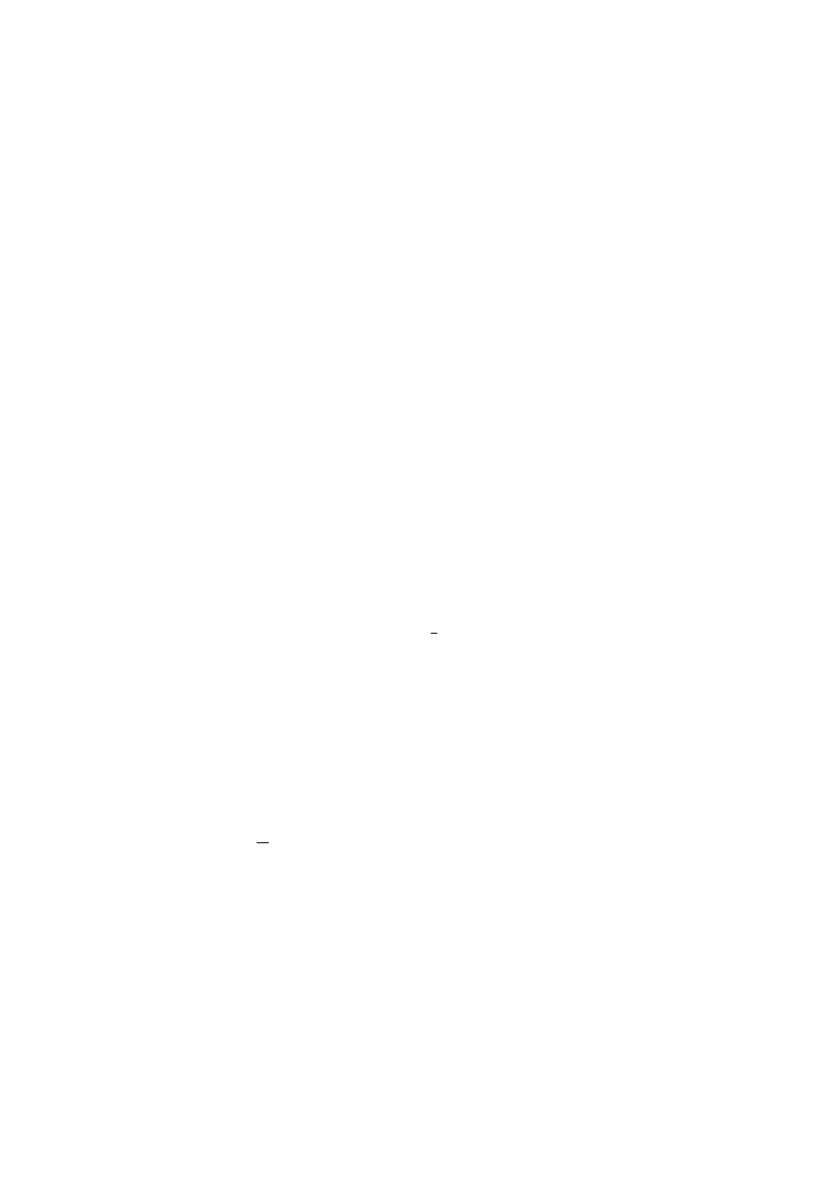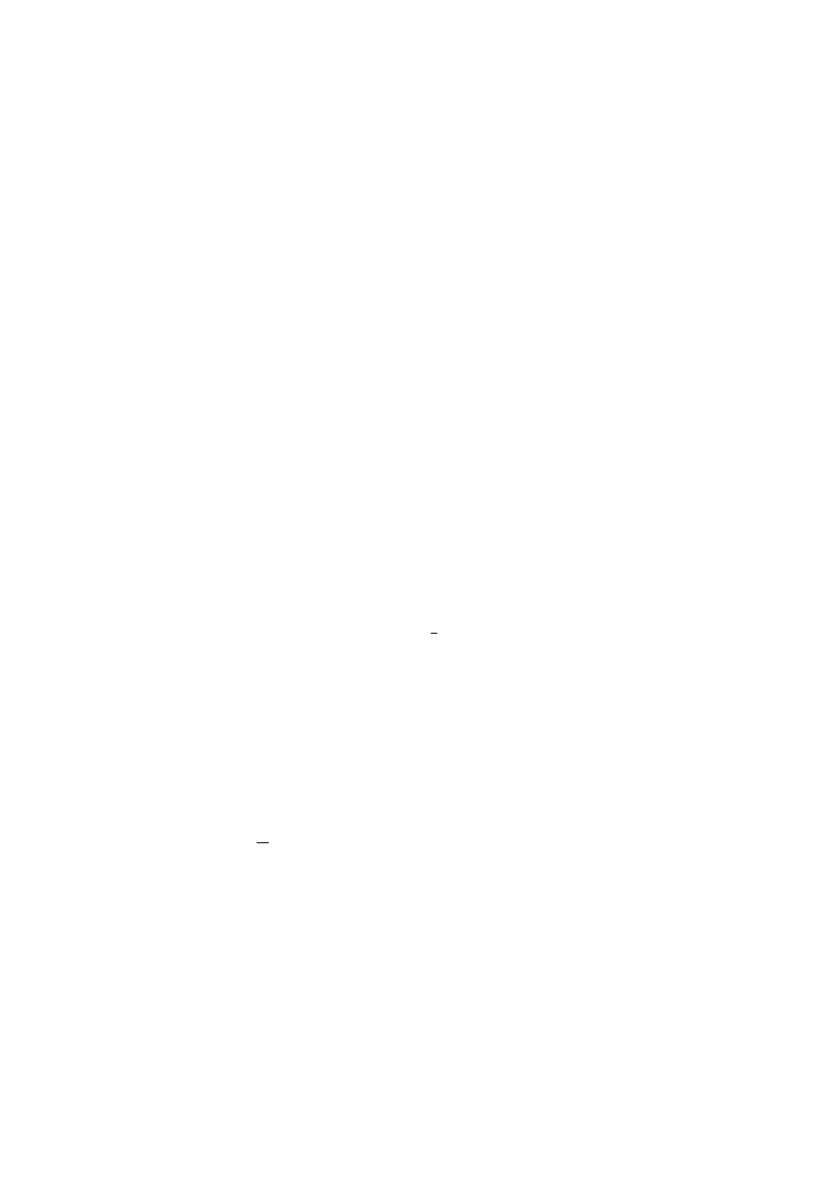
74
Parte Prima L’insegnamento di Lingua e cultura latina
4.2
Tipologie di errori
Abbiamo sottolineato come sia umanamente impossibile riprodurre un testo
senza deformarlo in qualche modo quando lo si ricopia a mano; ma quali sono
errori più diffusi? Prima di tutto, essi vanno distinti in due categorie:
alterazioni
“meccaniche”
e alterazioni “culturali”.
Le prime sono riconducibili a travisamenti o distrazioni del copista che ha mo-
dificato il testo originario in maniera del tutto involontaria. In concreto, si pos-
sono verificare i casi di seguito riportati.
>
L’amanuense ha ricopiato male singoli termini in quanto in difficoltà di-
nanzi a caratteristiche della scrittura antica non del tutto chiara (va detto,
infatti, che nei manoscritti più antichi non c’è divisione tra una parola e
l’altra; il sistema di abbreviazioni − molto adoperato nei documenti − facilita
le incomprensioni; la somiglianza nella riproduzione di singole lettere può
trarre in inganno chi scrive; quest’ultimo può non comprendere che lettere
maiuscole indicano numerali o, viceversa, lettere indicanti parole vengono
scambiate per numerali; la distrazione può condurre a uniformare la forma
grammaticale di due termini vicini alterando così le desinenze; ad un copista
abituato a leggere in un determinato tipo di scrittura poteva risultare ostica
la lettura di un altro tipo di scrittura e di qui le alterazioni).
>
Il copista ha omesso di riprodurre singole lettere, parole o intere righe. Si
parla in questo caso di
aplografia
quando per errore si è evitato di scrivere
due lettere, due sillabe, due parole uguali (es. in Plauto
Bacchides
79 i codici
presentano
te veniat
, corretto poi in
te eveniat
). In questa casistica di errori
rientrano anche i cosiddetti
saut du même au même
(“salto da una stessa parola
ad un’altra identica”): chi riproduce un testo tende a leggere e memorizzare
una stringa di testo e poi a riscriverla; ci sono casi in cui una stessa parola si
presenta due volte a breve distanza, per cui l’amanuense anziché riprendere
da dove si era interrotto è saltato più avanti lì dove c’era la seconda occorren-
za del termine, omettendo così una porzione del testo.
>
Si può verificare l’errore opposto, cioè non l’omissione, ma l’aggiunta di
lettere, parole o anche intere glosse. Il termine tecnico che si usa in questa
circostanza è
dittografia
(ad es. in Seneca
Epist.
78, 14 i codici presentano
quod
acerbum fuit ferre retulisse iucundum
,
corretto in seguito con il passaggio da
re-
tulisse
a
tulisse
). Sappiamo, poi, che i manoscritti antichi contenevano spesso
delle glosse che il copista autonomamente decideva di inserire nel testo sen-
za dare alcuna segnalazione; se in un testo poetico è facile rinvenire una tale
aggiunta perché l’ordito metrico risulta alterato, ben più difficile può essere
la sua individuazione in un brano di prosa.
>
Molto frequente è anche il caso di trasposizioni di lettere, sillabe, parole o
interi passi (la disattenzione del copista, ad esempio, portava ad invertire
l’ordine dei versi in un testo poetico).