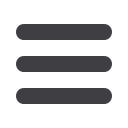
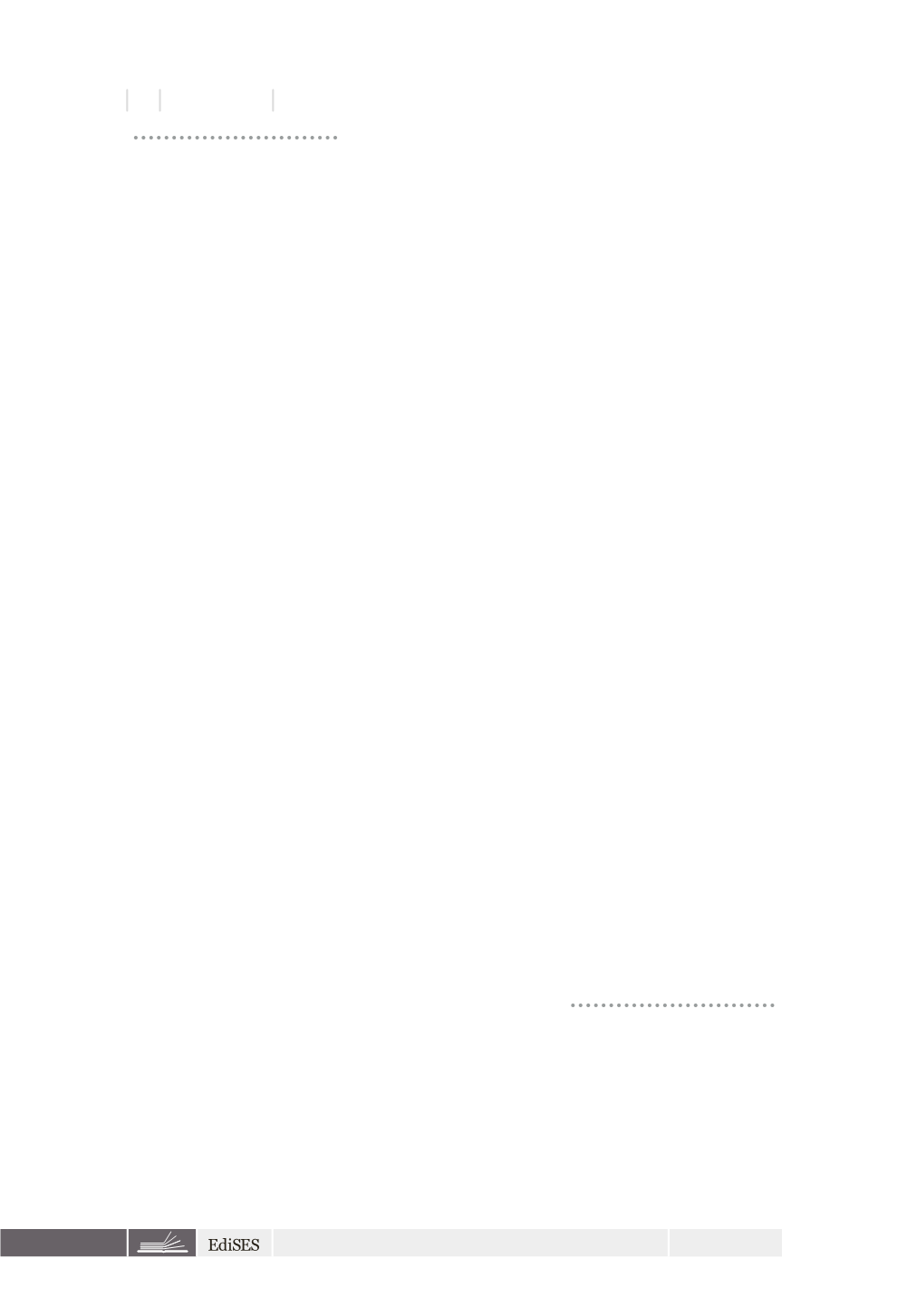
www.
edises
.it
72
Parte Seconda
Prove ufficiali commentate
Testo 2
Alla base dell’italiano – ossia del dialetto fiorentino trecentesco, che ne costitui-
sce il nucleo essenziale – come alla base di tutte le altre lingue romanze, non è il
latino classico, ma il latino volgare.
Il concetto di “latino classico” è da secoli passato in giudicato: si tratta del latino
scritto dai prosatori e dai poeti del periodo cosiddetto “aureo” della letteratura
latina, tra la fine della Repubblica romana e il principato augusteo; l’assegnazione
dell’aggettivo
classico
al termine
latino
si deve all’erudito Aulo Gellio (II secolo
d.C.), il quale applicò alla letteratura la divisione della popolazione romana in di-
verse classi economiche attribuita al re Servio Tullio (come alla prima classe ap-
partenevano i cittadini emergenti, per censo e potere, così furono detti “classici”
gli scrittori eccellenti, ai quali adeguarsi scrivendo in latino).
Molto più incerto e discusso, invece, il concetto di latino volgare. Intanto l’agget-
tivo
volgare
è parso inadeguato, giacché alle innovazioni parteciparono “tutte le
classi sociali, tutto il mondo romano, non il volgo soltanto” […]. Il termine di “lati-
no volgare” ha però una giustificazione, in quanto allude espressamente alla “pre-
minenza decisiva del fattore sociale”: “il maggiore impulso alle tendenze innova-
trici, soprattutto in campo fonetico, dovette venire dall’inurbarsi dei rustici” e
quelle innovazioni si generalizzarono per “l’erosione del ceto colto sotto la pres-
sione delle masse” (Roncaglia).
Ma, a parte la questione del nome, è lo stesso concetto che sfugge a una defini-
zione univoca. Suggestiva, proprio per la sua radicalità, è la posizione di chi tende
a vedere nel latino volgare nient’altro che il latino parlato da tutti gli strati della
popolazione in tutti i periodi della latinità […]. Il vantaggio di una tale prospettiva
è quello di sottolineare gli elementi di continuità tra latino arcaico e latino tardo.
Non c’è dubbio che molti tratti del latino arcaico, infrenati dalla scuola nel perio-
do classico, riappaiano e si impongano nell’età della decadenza […].
Diremo dunque, riassumendo, che il latino volgare, da cui muovono le lingue ro-
manze, è il latino parlato nell’uso quotidiano (in opposizione al latino classico che
riproduce la lingua letteraria cristallizzata nel periodo aureo), quale era venuto
atteggiandosi nell’età della decadenza: con diversi tratti arcaici, ma con molte
innovazioni; relativamente uniforme per quanto riguarda le strutture morfologi-
che fondamentali (in nessuna lingua romanza sopravvivono ad esempio il passivo
o il futuro organici: segno che già il latino volgare li aveva dismessi), ma spazial-
mente vario e differenziato soprattutto per il lessico.
[L. Serianni,
Lezioni di grammatica storica italiana
, Bulzoni Editore, Roma 1998]
3)
Con riferimento al testo, rispondi alla seguente domanda. Con l’accezio-
ne di “latino classico” ci si riferisce:
A.
alla lingua utilizzata nelle loro opere dagli scrittori tra la fine della Re-
pubblica romana e il principato augusteo
B.
alla lingua che costituisce la base per la formazione dell’italiano


















