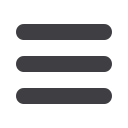

4
Parte Prima
Le Scienze dell’educazione: fondamenti
www.
edises
.it
po delle scienze umane contemporanee; poi, per aiutare lo stesso ad orientarsi
più facilmente nel dibattito odierno e per acquisire, altresì, consapevolezza di
una delle caratteristiche più significative delle scienze umane attuali, cioè la
continua osmosi tra concetti appartenenti a settori diversi.
1.1
Scienze umane, scienze dell’educazione e scienze sociali:
verso una denominazione comune
1.1.1
Dalle scienze umane …
La dizione “Scienze Umane” individua – avverte M.T. Moscato – «un macro
contenitore culturale, idealmente coincidente con le due classi di concorso
(A036, Filosofia e Scienze dell’Educazione e A037, Filosofia e Storia), ma
anche con i curricoli accademici delle lauree previste, rispettivamente, come
titolo di accesso alle stesse classi»
1
. A riempire questo contenitore sono tutte
quelle discipline che si occupano, quantunque a partire da prospettive diver-
se, dell’uomo segnandone l’esperienza, personale e collettiva.
Nel sostantivo
humanitas
si concentra in effetti l’identità e insieme il ruolo delle
scienze che fanno parte di questo macrocontenitore. Tali scienze – avverte la
su citata Moscato – «sarebbero “umane” perché “umanizzanti”, dotate cioè di
un intrinseco valore culturale e formativo, di una “dignità” privilegiata che le
“destina” all’umanizzazione dei cuccioli dell’uomo. “Scienze umane”, insom-
ma, perché hanno l’umanità (intesa come condizione umana) come oggetto di
indagine, ma anche perché hanno l’uomo (inteso come singola persona) come
soggetto destinatario»
2
.
Circa le origini di questa denominazione, essa si afferma solo verso la metà
degli anni Settanta del Novecento, allorquando all’orizzonte idealistico venne
contrapponendosi un altro ordine culturale. Attraverso un’azione di riforma
del sistema scolastico e dei suoi curricoli, Gentile aveva ridisegnato l’identità e
l’organizzazione interna dei diversi istituti.
In primis
i licei, tra i quali un ruolo
di prim’ordine spettava al Liceo Classico, da lui stesso considerato la scuola se-
condaria per eccellenza. I programmi del liceo classico erano strutturati in sen-
so storicistico e filosofico. A quest’ultimo, in particolare, Gentile riconosceva
un primato culturale e formativo intrinseco, tale da non necessitare di ulteriori
denominazioni che ne evidenziassero la funzione “umanizzante”.
Successivamente a Gentile, la contestazione dell’egemonia del sapere filosofi-
co portò ad un graduale riconoscimento del valore epistemologico delle altre
scienze, come psicologia e pedagogia (antiche sorelle minori della filosofia), e
della loro pari funzione “umanizzante”.
1
M.T. Moscato, 2007, p. 10.
2
Ivi
, p. 11.
















