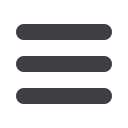

6
Parte Prima
Italiano
Svolgimento
Echeggiando il canto XXXI del
Paradiso
di Dante, in cui si riscontra un’ana-
loga similitudine, attraverso la quale il poeta paragona la sua insaziabile fame
di Dio a quella di un un pellegrino in estasi di fronte alla Veronica, il sonetto
petrarchesco affronta il tema della lontananza, presente anche in altri compo-
nimenti che si collocano in questa parte dei
Rerum vulgarium fragmenta
. Sacro
e profano duettano in questa come in altre liriche petrarchesche, rimandano
a un’antitesi più profonda: quella fra amore per Dio e attaccamento a Laura
e all’amore terreno. Quest’ultimo tema è centrale anche nel sonetto III del
Canzoniere,
Era il giorno ch’al sol si scoloraro.
Ricche di implicazioni a livello di
significato sono le simmetrie fra il
vecchierel canuto et biancho
(v. 1) da una parte
e l’io del poeta dall’altra: il primo
viene a Roma, seguendo ’l desio
(v. 9), laddove il
suo “desio” – una delle parole chiave della lirica – è quello di
mirar la sembianza
di Cristo, che confida di conoscere in Paradiso; il secondo, rivolgendosi alla
sua donna, le confida di essere alla ricerca della
disiata vostra forma vera
(v. 14)
e di andare cercando nel volto di ogni altra donna il suo volto. A un secondo
livello di interpretazione non può non essere sottolineato il tema del viaggio
spirituale: il sonetto si configura, in tal senso, come un testo allegorico in cui il
viaggio può intendersi come il percorso di un’anima verso la morte o verso l’a-
more. Parole chiave che rimandano al tema del viaggio sono
movesi
(v. 1),
viene
(v. 9),
vo
(v. 12), laddove la tensione del poeta verso la ricerca dell’immagine
della sua donna è espressa con l’uso del verbo “andare” al presente seguito dal
gerundio (
cerchand’io
) per indicare il protrarsi dell’azione, secondo un pro-
cedimento molto noto all’epoca e attestato più volte in Petrarca. Nel sonetto,
quindi, coesistono la dimensione spirituale e quella terrena, il momento ele-
giaco e sentimentale – presente soprattutto nella prima quartina, incentrata
sugli affetti familiari, e rappresentato dall’uso di vezzeggiativi (
il vecchierel
, v. 1;
la famigliuola
, v. 3), oltre che di aggettivi quali “dolce” (
dolce loco
, v. 2) o “caro”
(
caro padre
, v. 4) – e il momento tragico ed eroico, quello del viaggio che il
vecchio pellegrino compie
trahendo poi l’antiquo fianco
(v. 5), durante quello che
sembrerebbe essere l’ultimo segmento della sua vita (
per l’extreme giornate di sua
vita
, v. 6). Tutto, quindi, all’insegna della complessità, questo componimento
petrarchesco si presta a più interpretazioni ed è un mirabile saggio della poe-
tica di Petrarca.
















