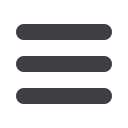

Testi in poesia – Francesco Petrarca
5
ne), CDE/CDE (a rime replicate, che possono anche presentarsi nella versione
CDE/DCE, con inversione delle prime due nella seconda terzina) o CDE/EDC
(a rime invertite). Nel caso del componimento petrarchesco in oggetto lo sche-
ma di rime è il seguente: ABBA/ABBA/CDE/CDE; siamo, quindi, in presenza
di due quartine a rime incrociate seguite da due terzine a rime replicate.
Esercizio 3
Figure retoriche principali
Punti chiave
■
Individuazione della similitudine su cui è incentrato il sonetto
■
Figure retoriche principali
■
Analisi del lessico
Svolgimento
Il sonetto è incentrato su un’ampia e unica similitudine, come rivela il v. 12 (
così,
lasso, talor vo cerchand’io
) grazie al quale si palesa la volontà del poeta di accostarsi
e paragonarsi a un vecchio pellegrino che si reca a Roma mosso dal desiderio di
vedere il panno con cui una delle pie donne, Veronica, avrebbe asciugato il san-
gue di Gesù, nella speranza di trovare in quella reliquia l’immagine di Cristo che
spera di vedere, un giorno, in Paradiso. Petrarca, infatti, alla stregua del
vecchierel
canuto et biancho
(v. 1) va cercando nel volto delle altre donne la vera immagine
della donna amata, che confida di vedere presto, non in cielo, ma in terra. Quan-
to alle altre figure retoriche riconoscibili nel testo, si rilevano una sineddoche al
v. 5 (
l’antiquo fianco
), in cui il poeta si riferisce all’intero corpo del vecchio rimar-
candone solo una parte, e un chiasmo al v. 8 (
rotto dagli anni, e dal camino stanco
),
che dà grande risalto ai due aggettivi “rotto” e “stanco” che qui si incrociano.
Nel sonetto emergono, poi, particolari scelte linguistiche e stilistiche tipiche del
linguaggio di Petrarca, caratterizzato da quello che è stato definito dagli studiosi
“monolinguismo”, distante dal “plurilinguismo” della
Divina commedia
dantesca.
Interessante l’uso della coppia sinonimica degli aggettivi
canuto et biancho
(v. 1),
nonché il ricorso a vezzeggiativi quali
il vecchierel
(v. 1) o
la famigliuola
(v. 3).
Esercizio 4
La poesia contiene alcuni temi tipici della poesia
petrarchesca. Il candidato li illustri con opportune citazioni,
individuando le parole chiave
Punti chiave
■
Temi principali del componimento
■
Parole chiave
■
Interpretazioni della lirica
















