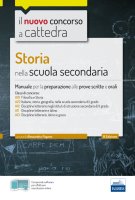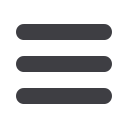

Capitolo 1
I fondamenti epistemologici della “storia” dall’antichità ad oggi
5
battaglia, un evento diventano storici solo quando risvegliano l’interesse dello
storico. Nel caso, ad esempio, del passaggio di Cesare sul Rubicone, è lo storico
ad aver deciso che, dal suo punto di vista, il passaggio in questione è più impor-
tante di tanti passaggi compiuti da milioni di individui prima o dopo Cesare
6
.
Non tutto ciò che accade è di importanza per lo sviluppo storico: ad esempio,
di quante portate fosse la colazione che facevano Luigi XVI e Maria Antonietta
non ha lo stesso valore “storico” delle scelte politiche del re di Francia. Eppure
potrebbe accadere che un domani “il numero di portate della colazione dei
reali di Francia” possa suscitare l’interesse di altri storici e diventare oggetto
di interpretazione. L’essere considerato o meno un fatto storico è solo una
questione di interpretazione. Alcuni fatti, eventi, documenti, immagini presi
singolarmente non hanno alcuna valenza storica; compito dello storico e an-
che dell’insegnante è quello di analizzarli, contestualizzarli, interpretarli, giu-
dicarli. Per la storiografia di matrice positivistica tutti i fatti sono considerati
ugualmente importanti, ma a noi piace sottolineare, invece, che la scuola non
deve rincorrere la cronaca e che compito degli insegnanti è quello di non far
apprendere le nozioni agli allievi, ma di aiutarli a maturare nello sviluppo di
capacità riflessive e critiche così da renderli autonomi nelle analisi e interpreta-
zioni. Del resto, come afferma lo storico J. Huizinga, “la storia non è il racconto
(cronaca) del passato ma fornisce una certa rappresentazione (interpretazio-
ne) di un certo passato, un quadro comprensibile di un frammento del passato
[…], è un dar forma al passato”
7
. Questa posizione è condivisa da B. Croce che
afferma che laddove manchi nello storico la capacità di interpretare e valutare,
essa si riduce a “filologia […] ignoranza fastosa che è l’erudizione”
8
.
1.4
Le categorie di “tempo” e “spazio” storico
Una volta risposto, se pur in parte per la sua complessità, alla domanda “che
cos’è la storia”, passiamo ad esaminare quelli che sono definiti come “i pre-
supposti ineliminabili di ogni ricostruzione storiografica”, il tempo e lo spazio
storico. La storia riguarda il tempo, ma quale tempo? E quale “spazio” storico?
Se la storia ha lo scopo di comprendere il presente a partire dalla conoscenza
del passato, non dovremmo prima comprendere il passato per far luce sul no-
stro presente? B. Croce affermerà che la storia ci “libera dal passato” e che è
sempre “storia contemporanea”, volendo affermare con questo una unità tra
passato e presente e che il lavoro dello storico, pur rivolto a ricostruire fatti
remoti e lontani, nasce sempre da un bisogno pratico di vivere il presente. L.
Febvre sosteneva che “la funzione sociale della storia era organizzare il passato
in funzione del presente”; F. Braudel identificò tre tempi della storia: quello
breve (il tempo degli avvenimenti), quello medio (il tempo della organizza-
6
Cfr. E. Carr,
Il fatto storico
, Einaudi, Torino 1976.
7
Cfr. J. Huizinga,
La scienza storica
, Laterza, Bari 1974.
8
Cfr. B. Croce,
op. cit.