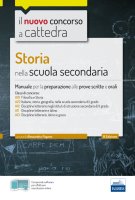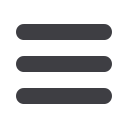
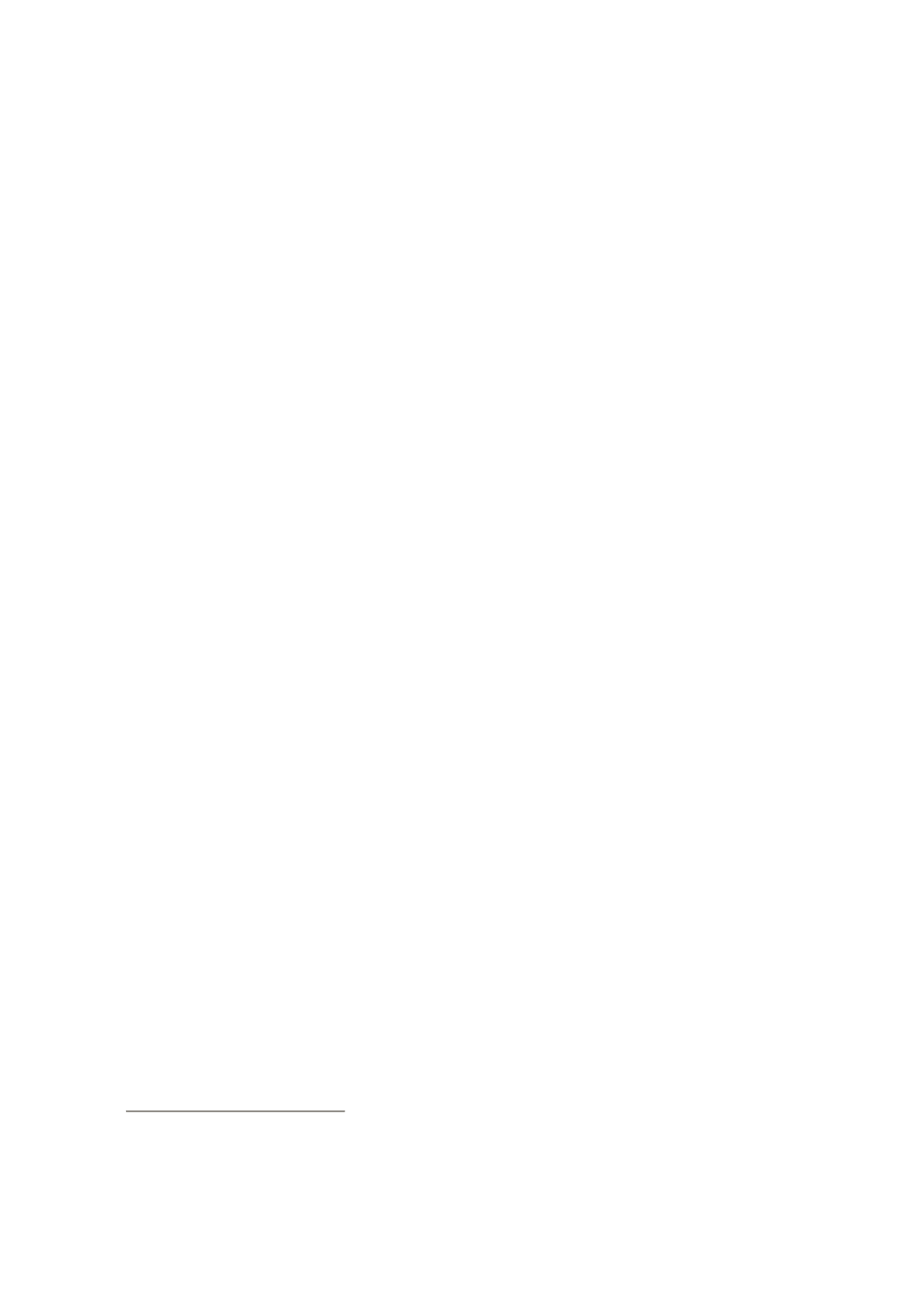
4
La storia: fondamenti epistemologici e metodologici
1.2
La storia come “ideologia” e la storia come “scienza”
È anche vero che molti insegnanti sostengono che la storia è “ideologia” e non
scienza, basti pensare alle motivazioni prettamente ideologiche che spingono
a scegliere un libro di testo piuttosto che un altro; la storia è “ideologia”, per-
ché i fatti storici sono “unici e irripetibili” a differenza di un esperimento di
fisica, perché lo storico opera una selezione di ciò che deve trattare alla luce
dei propri interessi e ideologie, perché lo storico, a differenza dello scienziato,
cerca di comprendere il perché degli avvenimenti dall’“interno” e non si limi-
ta a indagare le cause dei fatti come lo scienziato, perché lo storico esprime
sempre un giudizio, lo scienziato è invece avalutativo e oggettivo
4
. Questo vuol
dire che la storia è “ideologia” ma è anche “scienza”, se pensiamo all’approccio
metodologico. Infatti, come sostiene K. Popper, tutte le scienze, anche quelle
umanistiche, si rifanno ad un metodo scientifico e il metodo scientifico consi-
ste in tre passaggi fondamentali:
>
>
inciampiamo in qualche problema;
>
>
tentiamo di risolverlo, proponendo qualche teoria;
>
>
impariamo dai nostri sbagli, specialmente da quelli che sono resi presenti
nella discussione critica dei nostri tentativi di soluzione; in breve procediamo
per: problemi, teorie, critiche.
Se il metodo scientifico consiste nell’avanzare ipotesi e controllarle empiri-
camente, lo storico, quando risponde alle domande “cosa, come e perché è
accaduto”, procede allo stesso modo dello scienziato; solo quando, appurata
l’esistenza di un fatto,
come
e
perché
si è verificato, lo storico si chiede quale sia
il suo significato alla luce di una filosofia o ideologia, egli non fa più scienza
ma ideologia appunto. Quindi la storia è scienza, perché adopera un metodo
scientifico, che può diventare ideologia
5
. Il compito a cui il docente è chiamato
è quello di evitare il pericolo dell’indottrinamento ideologico e fornire agli stu-
denti una conoscenza dei fatti a più largo spettro, inserendoli sempre in quadri
di riferimento storici più ampi, in quella che K. Popper definisce “la logica
della situazione” (esempio il tema della questione ugonotta nel tema più vasto
della Riforma e Controriforma cattolica). L’apprendimento secondo la “logica
della situazione” rende meno mnemonico e più riflessivo lo studio della storia
e, solo offrendo allo studente le strutture logiche di ragionamento, egli potrà
riflettere criticamente su ciò che viene spiegato.
1.3
Cos’è un “fatto storico”?
Come faceva notare E. Carr un fatto storico è, per dirla parafrasando Pirandel-
lo, “come un sacco”, ovvero ognuno ci mette qualcosa dentro e un fatto, una
4
Cfr. P. Masat Lucchetta,
Epistemologia e Storiografia
, Editrice La Scuola, Brescia 1981.
5
Cfr. K. Popper,
Problemi, scopi e responsabilità della scienza
, in Scienza e filosofia, trad. it., Ei-
naudi, Torino 1969.