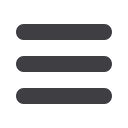

Finalità e struttura dell’opera
La scuola italiana ha compiuto grandi progressi negli ultimi decenni e sta
ancora facendo molti sforzi per adeguarsi alle indicazioni europee nel campo
dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue. L’internazionalizzazione
e lo sviluppo della dimensione europea non sono, tuttavia, obiettivi facilmente
raggiungibili, poiché mirano ad ottenere il più alto grado di uniformità
partendo da sistemi scolastici molto diversi fra di loro e radicati in un tessuto
culturale eterogeneo. Né sarebbe sufficiente, qualora fosse possibile, cancellare
le prassi obsolete per adottare quelle degli altri Paesi europei, in quanto non si
possono sradicare le tradizioni culturali specifiche del proprio Paese.
Rivolto ai candidati al
concorso a cattedra
nella
scuola primaria
che devono
sostenere le prove di lingua inglese, questo manuale, ricco di spunti operativi
per una didattica efficace e partecipata, vuole essere un mezzo per conoscere
i bisogni del discente della società del terzo millennio, che deve assiduamente
confrontarsi con parlanti di altre culture, e per una riflessione sulle attuali
esigenze comunicative in un mondo globalizzato.
Il
primo capitolo
parte da una riflessione sui concetti di
plurilinguismo
e
pluriculturalismo
,
per poi soffermarsi sulle proposte europee nell’ultimo
decennio e sulle strategie fortemente auspicate a livello europeo e recepite,
almeno formalmente, da tutti gli Stati. Pur essendo consapevoli della diffusione
del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
, si è scelto di dedicare
molta attenzione a questo strumento, affinché tutti i docenti o aspiranti tali
possano conoscere le variegate opportunità che esso offre sia all’insegnante
sia all’allievo, in modo che ognuno lo recepisca secondo le proprie esigenze
formative. Soprattutto si vuole evidenziare come la sua duttilità e flessibilità
siano le caratteristiche che lo rendono un mezzo di lavoro estremamente utile
per tutti, anche per quanti operano a livello base. La sua autorevolezza infatti
non deriva dall’essere prescrittivo, ma al contrario dal presentarsi come un
contenitore in cui nulla è stato dimenticato o lasciato al caso.
Il testo procede poi con la disamina del
Portfolio
e del
Passaporto delle lingue
.
Tali documenti tendono ad uniformare in tutta Europa gli aspetti relativi alla
trasferibilità delle competenze e alla trasparenza della valutazione, andando
ad incidere, nel contempo, sia sulla professionalità del docente sia sul
monitoraggio della progressione dell’apprendimento dei discenti.
A seguire tale trattazione, che aiuta a capire in quale direzione si stia muovendo
l’Europa, nel
secondo capitolo
si è indagata la realtà della scuola italiana del
primo ciclo, in cui le recenti riforme stanno mettendo in pratica la dimensione
europea. Dopo una panoramica sull’insegnamento delle lingue straniere nella
scuola primaria, in un’ottica diacronica e verticale, si è proceduto con un’analisi
sia della figura del docente sia degli obiettivi specifici di apprendimento relativi
alle lingue straniere, anche in considerazione delle
Indicazioni Nazionali
del


















