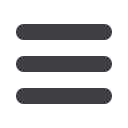

www.
edises
.it
Finalità e struttura dell’opera
Il presente lavoro è concepito come supporto per tutti coloro che stanno per
affrontare le prove del concorso a cattedra. A tale finalità si affianca anche la
volontà di renderlo uno strumento di consultazione per i futuri docenti nella
loro professione.
Il manuale è strutturato in più parti. La
prima parte
ha carattere metodolo-
gico-didattico ed ordinamentale e propone una serie di riflessioni sulle caratte-
ristiche interdisciplinari della fisica, sulla didattica secondo le scienze integrate
e sul metodo scientifico, fin dalla prima definizione che Galilei ne ha dato nel
suo “Saggiatore”. Il lettore avrà modo di entrare in contatto con il pensiero di
Galilei, leggendolo direttamente, e senza alcun filtro. L’intento di questa scelta
è quello di dimostrare che tuttora il metodo scientifico galileiano può essere
un valido punto di riferimento nella pratica di laboratorio della scuola secon-
daria di secondo grado.
Nella
seconda parte
, dedicata alle competenze disciplinari, vengono riper-
corsi in modo sintetico, ma esaustivo, i contenuti oggetto del programma d’esa-
me della classe. In particolare, il primo capitolo è di carattere storico e descrive
i momenti che hanno segnato l’evoluzione del pensiero scientifico, dalla rivo-
luzione astronomica alle due rivoluzioni industriali, fino alla rivoluzione del
Novecento, che presenta interessanti risvolti filosofici. Per la stesura di questo
capitolo si è fatta una scelta forse singolare, che in parte riprende quella accen-
nata nella prima parte del volume. Si è deciso di riportare stralci direttamente
dalle fonti primarie. È opinione di chi scrive che tale scelta possa contraddi-
stinguere quest’opera in modo significativo dalle altre destinate al concorso a
cattedra e all’esercizio della professione. La lettura diretta di Galilei, Newton,
Carnot, Watt, Einstein, Planck, de Broglie e tante altre favolose menti che han-
no costellato la storia della fisica funge da stimolo sia per il docente che per lo
studente. Questa lettura aiuta a contestualizzare socialmente e storicamente le
scoperte, ad indossare realmente gli “occhiali dello scienziato”. In tal modo si
può cogliere il senso profondo che ogni scienziato ha voluto dare alle proprie
conquiste e la grande dedizione e passione che lo hanno guidato nella sua at-
tività di ricerca. Questo aspetto può aiutare la fisica ad inserirsi a pieno titolo,
come ogni disciplina dal profondo carattere formativo, anche in un percorso
di studi umanistici.
Alla scelta di riportare stralci importanti di fonti primarie si è affiancata la
volontà di presentare anche gli scritti in lingua originale. Pertanto, il lettore
avrà la possibilità di leggere Newton in latino, Carnot in francese, Watt in in-
















