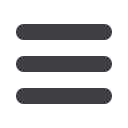

www.
edises
.it
VIII
Finalità e struttura dell’opera
glese o Einstein in tedesco. Ci è sembrato il modo migliore per stimolare con-
testualmente le abilità linguistiche dei candidati, che avranno l’opportunità di
cimentarsi nelle prove del concorso anche sotto questo profilo.
I capitoli successivi entrano nel vivo della disciplina, illustrandone tutte le
branche in modo approfondito, seguendo fedelmente il programma del con-
corso. Per la compilazione di questi capitoli si è attinto a fonti sia di livello uni-
versitario sia di livello scolastico, al fine di creare la giusta miscela che fosse frui-
bile dal più ampio numero di candidati. Per questa scelta si è tenuto presente
che i destinatari del volume possono avere percorsi formativi distinti, ciascuno
con le proprie caratteristiche e peculiarità.
L’
ultima parte
del testo è infine incentrata sulla pratica dell’attività d’aula e
contiene esempi di
Unità di Apprendimento
utilizzabili come modello per una
didattica metacognitiva e partecipativa.
Nel volume si propone una modalità di approccio ai contenuti disciplinari
che concilia sia l’aspetto formale sia l’aspetto maggiormente pratico ed intui-
tivo. In tal modo, si spera di andare incontro sia a coloro che hanno avuto
modo di affrontare la disciplina in maniera completa e sistematica sia a coloro
che l’hanno studiata ponendo maggiore enfasi solo sugli aspetti principali e
fondanti.
A tutte le riflessioni appena presentate se ne sono aggiunte altre di carattere
generale per la stesura dell’opera. Negli ultimi due decenni la “scuola della
programmazione” ha lasciato definitivamente il posto alla “scuola dell’autono-
mia e della personalizzazione”. In questi due termini è riassunto tutto il moder-
no approccio della didattica. L’autonomia scolastica, declinata in tutte le sue
forme, permette a ciascuna scuola di creare un proprio curricolo da proporre
alla sua utenza. Questo curricolo è il frutto dell’interazione della istituzione
scolastica con il “territorio” e con tutti gli stakeholder. Sicché ciascuna scuola
diventa una cellula vitale nella realtà sociale ed economica del territorio ed è
demandata a svolgere una o più funzioni specifiche, di carattere fondamentale
per la realtà che la circonda. In tal modo, i curricoli scolastici vengono decli-
nati sul mondo reale e l’istituzione scolastica finisce con l’avvicinarsi ad esso.
Alle caratteristiche specifiche di ogni singola istituzione scolastica si aggiun-
gono gli stili cognitivi e le particolari inclinazioni di ogni singolo alunno. Ecco,
quindi, che subentrano la personalizzazione del percorso di apprendimento
e la capacità del docente di adeguare la propria didattica non più al contesto
classe, dove potrebbe essere recepita solo “in media” e non “singolarmente”,
ma piuttosto al singolo alunno, quale “realtà” cognitiva specifica e irripetibile.
Perché la personalizzazione dell’apprendimento abbia luogo, il docente deve
avvalersi di un’approfondita conoscenza dei contenuti che vuole proporre. In
questo modo, egli riesce a declinarli con proprietà ed incisività, mettendo in
rilievo tutti gli aspetti critici. L’attenzione si sposta quindi dalla pratica di inse-
gnamento del docente al processo di apprendimento dello studente. Questo
vuol dire che la didattica trasmissiva, fatta di una mole interminabile di nozioni
che allo studente rischiano di apparire vuote di significati, occorre sostituire
una didattica improntata alla maturazione delle competenze. Gli alunni devo-
















