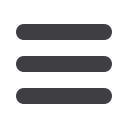

www.
edises
.it
Finalità e struttura dell’opera
Quante volte, nella nostra esperienza quotidiana di insegnanti, ci siamo sentiti dire,
e ci sentiremo ripetere: “Ma a che serve il greco?”. Domanda quanto più ricorrente e
preoccupante se proviene da uno studente poco interessato e motivato allo studio, o
da un allievo che, per i motivi più svariati, non riesce a raggiungere risultati di protto
soddisfacenti.
Possiamo provare a spiegare agli studenti il signicato e l’utilità dello studio del greco, a
partire da esempi concreti legati alla loro esperienza di adolescenti di oggi che parlano
la lingua italiana.
Tanto per cominciare, possiamo far osservare che molti termini dell’italiano hanno la loro
derivazione etimologica proprio dalla lingua greca, motivo per il quale imparare il signica-
to di molte parole greche può essere di aiuto per utilizzare l’italiano in modo più consape-
vole e corretto, diventando così più competenti nell’uso dei propri mezzi linguistici.
Soprattutto al primo biennio, però, quando lo studio della lingua si riduce spesso quasi
esclusivamente alla memorizzazione di un repertorio di regole e all’esercizio di applica-
zione delle stesse, studiare il greco rappresenta per gli studenti soltanto impegno e fati-
ca e, in molti casi, apprendimento noioso di contenuti e di metodi che appaiono privi
di alcuna utilità pratica. Non serve in questo caso ricorrere a giusticazioni
nobilitanti
dello studio del greco, come ad esempio “studiare la lingua greca (o quella latina) ti
serve ad allenare la mente, a esercitare le capacità logiche, a favorire la concentrazione,
a potenziare la memoria, a perfezionare le abilità di analisi e di sintesi”. Tutto questo
gli studenti lo sanno già, e seppure non comprendono sino in fondo il senso di simili
dichiarazioni, frasi come queste le sentono ripetere da anni, da genitori, familiari e in-
segnanti delle scuole precedentemente frequentate, che con siffatte motivazioni hanno
provato a orientarli alla scelta del liceo classico. Durante i primi due anni, segnati dalla
fatica di uno studio impegnativo e stancante, è più utile probabilmente rassicurarli che
quell’apprendimento non è sterile, né ne a se stesso, ma rappresenta solo il presup-
posto, indispensabile peraltro, perché in seguito possano affrontare lo studio di una
civiltà, vale a dire confrontarsi con idee, pensieri, visioni del mondo. E perché questo
mondo non rimanga solo un lontano miraggio, si può iniziare a fornire loro già qualche
assaggio, accompagnando lo studio, prevalentemente linguistico, con lo svolgimento di
brevi e semplici percorsi tematici su aspetti della vita e della cultura greca.
Passati al secondo biennio, nalmente si confronteranno con gli autori. Comprenderanno
che la conoscenza del nostro passato è il fondamento della nostra identità di uomini e don-
ne di oggi. Possiamo capire il presente solo conoscendo ciò che è accaduto prima.
Ri#ettere su temi corposi e complessi, come quello della nascita della democrazia,
dell’istituzione delle leggi, del rapporto tra uomo e divinità, delle relazioni tra universo
maschile e universo femminile, servirà a capire questioni e problemi del mondo con-
temporaneo. D’altra parte, ragionare su altri argomenti, come l’accezione ristretta del
concetto stesso di democrazia greca, la schiavitù, la misoginia nel mondo greco, signi-
















