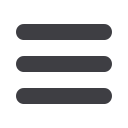

www.
edises
.it
VI
Prefazione
come contesto di attività e situazioni che rispetti e promuova la
centralità dell’alunno, il quale elabora il proprio apprendimento
per vie multiple, caratterizzate da tratti di irriducibile e preziosa
singolarità. In questo contesto, si affermano forme interattive e
collaborative di apprendimento, e situazioni e metodi laboratoria-
li concorrono ad esaltare l’espressione delle proprie potenzialità
da parte dell’alunno e a connotare l’apprendimento come attività
costruttiva. L’opposto, dunque, di una impostazione trasmissiva
- espressamente stigmatizzata dalle
Indicazioni
- alla quale non si
può più riconoscere alcuna plausibilità, sebbene essa possa risulta-
re impegnativa, per la consapevolezza e il lavoro progettuale che
richiede.
Analogo discorso vale, ovviamente, per le
Indicazioni Nazionali
e le
Linee Guida
della scuola secondaria di secondo grado.
Sulla base di queste premesse, il volume è suddiviso in parti. La
prima parte
presenta e mette a confronto i principali
modelli di
apprendimento
e il loro impiego nella
progettazione didattica
:
le conoscenze in materia di apprendimento sono, infatti, la base
su cui costruire e pianificare l’attività d’aula, rappresentando un
imprescindibile prerequisito per qualsiasi insegnante che aspiri a
condurre una lezione efficace. Si tratta di un interessante e appro-
fondito
excursus
, da Piaget a Baron, da Sternberg a Gardner e alla
sua teoria delle “intelligenze multiple”, agli utilissimi apporti del
costruttivismo socio-culturale, ai più recenti contributi offerti dalle
neuroscienze. L’apprendimento, come già detto, non va più con-
siderato secondo un’ottica di mera trasmissione nozionistica dal
docente al discente, ma come fatto essenzialmente “sociale”, che
si svolge in un contesto-classe in costante relazione e mediazione
con gli altri. Un apprendimento che vuole e deve essere, come ve-
dremo, cooperativo e collaborativo. Vi è poi la parte dedicata alla
programmazione e alla valutazione (
chi valuta? cosa si valuta? come
si valuta?
), nella quale si analizzano le funzioni della valutazione e
gli strumenti più efficaci per metterla in pratica.
La
seconda parte
affronta anzitutto il tema – oggi più che mai
importante – della multidisciplinarità, fondamentale per poter
comprendere la realtà nella sua totalità, abbandonando l’ormai
datata separazione tra le discipline: verranno esaminati i diversi
modi di “fare lezione”
– dalla lezione frontale a quella partecipata
– e i diversi
metodi
, in particolare quelli che utilizzano le nuove
tecnologie. La lezione frontale, di lunga tradizione, offre indubbi
















