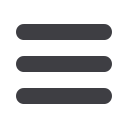
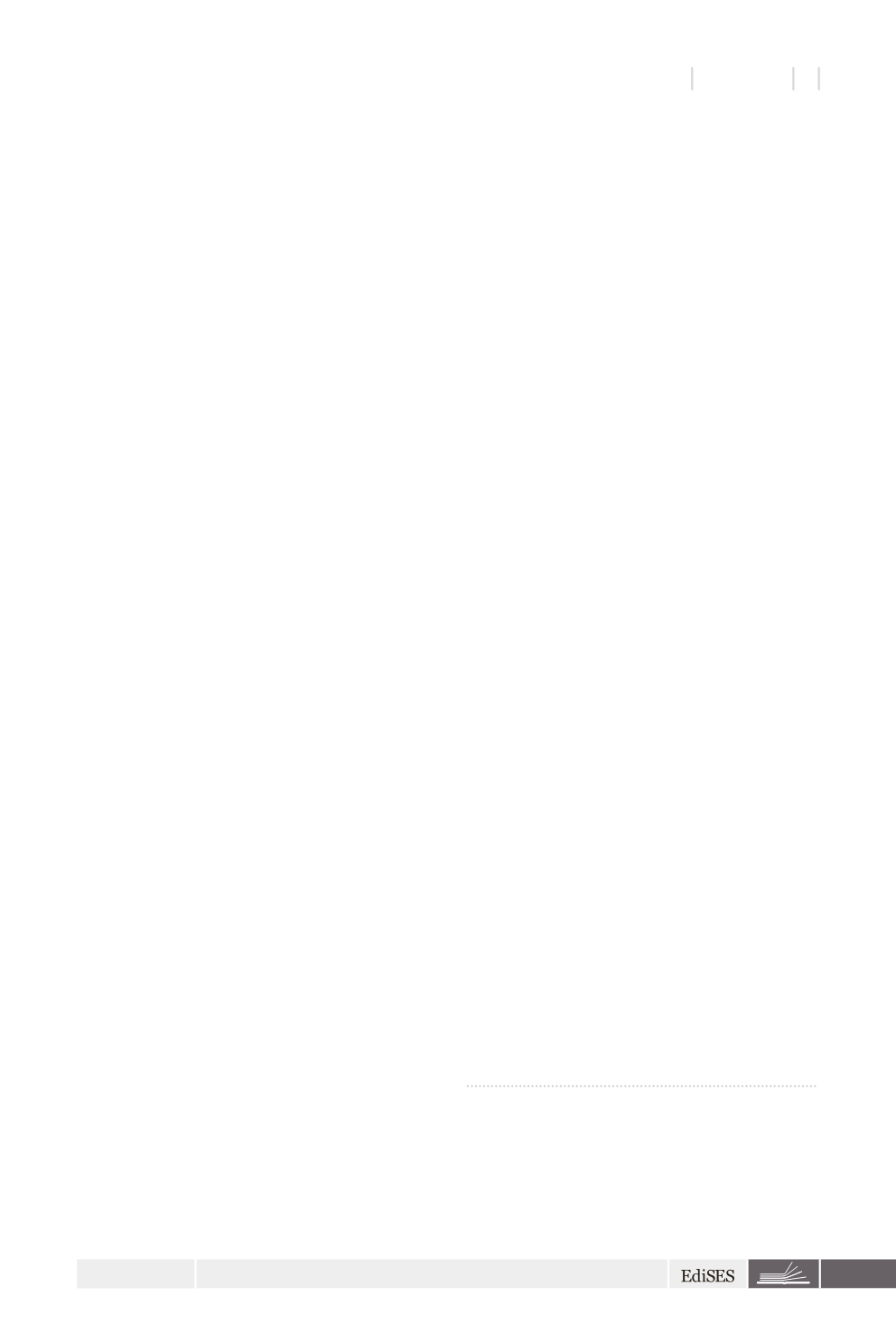
PROVE UFFICIALI
a.a. 2011/2012
5
www.
edises
.it
creatore, Arthur Conan Doyle. Il cono-
scitore d’arte è paragonabile al detective
che scopre l’autore del delitto (del qua-
dro) sulla base di indizi impercettibili ai
più. Gli esempi della sagacia di Holmes
nell’interpretare orme nella fanghiglia,
ceneri di sigaretta e così via sono, com’è
noto, innumerevoli. Vedremo tra poco le
implicazioni di questo parallelismo. Pri-
ma però sarà bene riprendere un’altra
preziosa intuizione di Wind: «Ad alcuni
tra i critici di Morelli sembrava strano il
dettame che “la personalità va cercata
là dove lo sforzo personale è meno in-
tenso”. Ma su questo punto la psicologia
moderna sarebbe certamente dalla par-
te di Morelli: i nostri piccoli gesti incon-
sapevoli rivelano il nostro carattere più
di qualunque atteggiamento formale, da
noi accuratamente preparato». “I nostri
piccoli gesti inconsapevoli...”: alla gene-
rica espressione “psicologia moderna”
possiamo sostituire senz’altro il nome
di Freud. Le pagine di Wind su Morelli
hanno infatti attirato l’attenzione degli
studiosi su un passo, rimasto a lungo
trascurato, del famoso saggio di Freud
Il
Mosè
di
Michelangelo
(1914). Ridurre
quest’influsso, come è stato fatto, al solo
saggio sul
Mosè
di Michelangelo, o in
genere ai saggi su argomenti legati alla
storia dell’arte significa limitare indebi-
tamente la portata delle parole di Freud:
«Io credo che il suo metodo [di Morelli]
sia strettamente apparentato con la tec-
nica della psicoanalisi medica». Ma che
cosa poté rappresentare per Freud – per
il giovane Freud, ancora lontanissimo
dalla psicoanalisi – la lettura dei saggi
di Morelli? È Freud stesso a indicarlo; la
proposta di un metodo interpretativo im-
perniato sugli scarti, sui dati marginali,
considerati come rivelatori. In tal modo,
particolari considerati di solito senza
importanza, o addirittura triviali, «bas-
si», fornivano la chiave per accedere ai
prodotti più elevati dello spirito umano;
«i miei avversari» scriveva ironicamente
Morelli (un’ironia fatta apposta per pia-
cere a Freud) «si compiacciono di qua-
lificarmi per uno il quale non sa vedere
il senso spirituale di un’opera d’arte e
per questo dà una particolare importan-
za a mezzi esteriori, quali le forme della
mano, dell’orecchio, e persino,
horribile
dictu
, di così antipatico oggetto qual è
quello delle unghie». Inoltre, questi dati
marginali erano, per Morelli, rivelatori,
perché costituivano i momenti in cui il
controllo dell’artista, legato alla tradi-
zione culturale, si allentava per cedere
il posto a tratti puramente individuali,
«che gli sfuggono senza che egli se ne ac-
corga». Ancor più dell’accenno, in quel
periodo non eccezionale, a un’attività
inconscia, colpisce l’identificazione del
nucleo intimo dell’individualità artistica
con gli elementi sottratti al controllo del-
la coscienza.
6) Perché, secondo Morelli, i mezzi este-
riori sono i più importanti per l’attribu-
zione delle opere? (
vedi Brano I
)
A. Perché sono quelli a cui un artista dà
meno importanza
B. Perché sono quelli a cui nessuno
guarda con attenzione
C. Perché sono quelli più facilmente
imitabili
D. Perché sono quelli su cui agiscono di
più i tratti tipici della scuola di appar-
tenenza
E. Perché sono quelli che dimostrano
maggiormente i tratti più individuali
di un artista
7) Il metodo morelliano (
vedi Brano I
):
A. fu accettato dagli storici dell’arte,
perché permetteva di risolvere tutti i
problemi di attribuzione


















