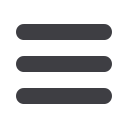

4
PROVE UFFICIALI
www.
edises
.it
so russo, Ivan Lermolieff; a tradurli in
tedesco era stato un altrettanto ignoto
Johannes Schwarze. Gli articoli propo-
nevano un nuovo metodo per l’attribu-
zione dei quadri antichi, che suscitò tra
gli storici dell’arte reazioni contrastan-
ti e vivaci discussioni. Solo alcuni anni
dopo l’autore gettò la duplice maschera
dietro a cui si era nascosto. Si trattava
infatti dell’italiano Giovanni Morelli
(cognome di cui Schwarze è il calco e
Lermolieff l’anagramma, o quasi). E di
«metodo morelliano» gli storici dell’arte
parlano correntemente ancora oggi. Ve-
diamo brevemente in che cosa consisteva
questo metodo. I musei, diceva Morelli,
sono pieni di quadri attribuiti in manie-
ra inesatta. Ma restituire ogni quadro al
suo vero autore è difficile: molto spesso
ci si trova di fronte a opere non firmate,
magari ridipinte o in cattivo stato di con-
servazione. In questa situazione è indi-
spensabile poter distinguere gli originali
dalle copie. Per far questo, però (diceva
Morelli) non bisogna basarsi, come si
fa di solito, sui caratteri più appariscen-
ti, e perciò più facilmente imitabili, dei
quadri: gli occhi alzati al cielo dei per-
sonaggi di Perugino, il sorriso di quelli
di Leonardo, e così via. Bisogna invece
esaminare i particolari più trascurabili,
e meno influenzati dalle caratteristiche
della scuola a cui il pittore apparteneva:
i lobi delle orecchie, le unghie, la forma
delle dita delle mani e dei piedi. In tal
modo Morelli scoperse, e scrupolosa-
mente catalogò, la forma di orecchio
propria di Botticelli, quella di Cosmé
Tura e così via: tratti presenti negli origi-
nali ma non nelle copie. Con questo me-
todo propose decine e decine di nuove
attribuzioni in alcuni dei principali mu-
sei d’Europa. Spesso si trattava di attri-
buzioni sensazionali: in una Venere sdra-
iata conservata nella galleria di Dresda,
che passava per una copia di mano del
Sassoferrato di un dipinto perduto di
Tiziano, Morelli identificò una delle po-
chissime opere sicuramente autografe di
Giorgione. Nonostante questi risultati, il
metodo di Morelli fu molto criticato, for-
se anche per la sicurezza quasi arrogante
con cui veniva proposto. Successivamen-
te fu giudicato meccanico, grossolana-
mente positivistico, e cadde in discredi-
to. (È possibile, d’altra parte, che molti
studiosi che ne parlavano con sufficienza
continuassero a servirsene tacitamente
per le loro attribuzioni).
Il rinnovato interesse per i lavori di Mo-
relli è merito del Wind, che ha visto in
essi un esempio tipico dell’atteggiamen-
to moderno nei confronti dell’opera
d’arte – atteggiamento che porta a gu-
stare i particolari anziché l’opera com-
plessiva. In Morelli ci sarebbe, secondo
Wind, un’esasperazione del culto per
l’immediatezza del genio, da lui assimi-
lato in gioventù, a contatto con i circoli
romantici berlinesi. È un’interpretazio-
ne poco convincente, dato che Morelli
non si poneva problemi di ordine este-
tico (ciò che gli venne poi rimprovera-
to) ma problemi preliminari, di ordine
filologico. In realtà, le implicazioni del
metodo proposto da Morelli erano diver-
se, e molto più ricche. «I libri di Morelli,
– scrive Wind, – hanno un aspetto piut-
tosto insolito se paragonati a quelli degli
altri storici dell’arte. Essi sono cosparsi di
illustrazioni di dita e di orecchie, accura-
ti registri di quelle caratteristiche minu-
zie che tradiscono la presenza di un dato
artista, come un criminale viene tradito
dalle sue impronte digitali.., qualsiasi
museo d’arte studiato da Morelli acqui-
sta subito l’aspetto di un museo crimina-
le...». Questo paragone è stato brillante-
mente sviluppato da Castelnuovo, che ha
accostato il metodo indiziario di Morelli
a quello che quasi negli stessi anni veni-
va attribuito a Sherlock Holmes dal suo


















