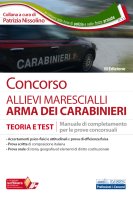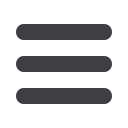

Capitolo 1
Il Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
5
www.
edises
.it
Il primo nucleo con cui i Carabinieri cominciarono ad operare era costituito da 27 ufficiali e
776 tra sottoufficiali e truppa. Il Corpo venne articolato in Divisioni, una per provincia, co-
mandata da un capitano. Ogni divisione aveva sotto di sé una serie di luogotenenze, guidate
da un luogotenente o da un sottotenente. L’ultimo anello della catena era costituito dalle Sta-
zioni, capillarmente distribuite su tutto il territorio e comandate da marescialli o brigadieri.
Uno dei primi problemi che sorsero con l’istituzione di questo Corpo fu legato al criterio di
reclutamento. Inizialmente il problema venne risolto dando accesso quasi esclusivo a chi aves-
se prestato servizio per quattro anni in altri corpi, garantendo così la presenza di persone che
avessero già una formazione adeguata alla disciplina e alla vita militare. Altri requisiti erano
legati alla statura (non meno di 1,75 metri) e alla capacità di leggere e scrivere: visto il diffuso
analfabetismo e la dieta povera di proteine, si trattava di requisiti molto severi per l’epoca. Al-
trettanto rigorosi erano i criteri di reclutamento degli ufficiali, che venivano scelti prevalente-
mente sulla base delle competenze acquisite nelle armate napoleoniche. Un incentivo da non
sottovalutare nel reclutamento volontario era rappresentato dalla paga: cinquecento lire per
un carabiniere a piedi e mille per uno a cavallo.
La Determinazione sovrana del 9 novembre 1816 decise una riorganizzazione del Corpo, isti-
tuendo un comando di corpo retto da un colonnello e creando presso il comando un consi-
glio di amministrazione che assicurasse la completa autonomia amministrativa. Inoltre, il nu-
mero delle Divisioni passò da dodici a sei e fu creato il livello ordinativo di compagnia con 19
compagnie agli ordini di capitani o luogotenenti anziani. Venne disposto che il reclutamento
ordinario si effettuasse dai reggimenti di fanteria e cavalleria, mentre un reclutamento facol-
tativo poteva avere luogo tra volontari civili dotati di spiccate qualità. La suddetta determi-
nazione sovrana sanciva “ventuno incumbenze” che definivano il servizio istituzionale, anco-
ra oggi ad esse ispirato. Tra queste citiamo l’attività informativa, consistente nel “procurarsi e
raccogliere tutte le notizie possibili sopra i delitti che si fossero commessi, e sovra i loro auto-
ri…”, l’arresto in flagranza di reato, il controllo sul porto abusivo di armi e sui giochi d’azzar-
do, le prescrizioni relative alla tutela dell’ambiente, come l’arresto dei devastatori di boschi, la
lotta al contrabbando, le disposizioni volte alla tutela dei negozianti e del servizio postale, il
servizio di frontiera, ed altro ancora.
Nel 1822, Carlo Felice riordinò la disciplina di questa forza armata attraverso il “Regolamen-
to Generale del Corpo dei Carabinieri Reali”, che sarebbe stato alla base di tutti i successivi,
fino ai nostri giorni. Non è un documento organizzativo, ma un vero e proprio libro di oltre
250 pagine che regolamentava nello specifico ogni aspetto del Corpo. Oltre alle disposizioni
di servizio, il regolamento in esame sancisce alcuni principi duraturi: i carabinieri, tranne che
per il servizio d’ordinanza (cioè trasmissione di dispacci urgenti), devono sempre essere alme-
no in due; devono considerarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza ed a qualunque
ora; devono sempre avere un contegno distinto, fermo, dignitoso, calmo, ma anche imparzia-
le ed umano.
Anche il reclutamento era più selettivo, perché il candidato doveva: avere un’età compresa tra
i 25 e i 40 anni, saper leggere e scrivere, essere preferibilmente celibe o vedovo senza figli, non
avere precedenti penali, aver servito per almeno quattro anni in un altro corpo dell’armata con
un certificato di buona condotta e salute, essere alto 39 once per la fanteria e 40 per la caval-
leria (circa 1,75 metri). Le nuove reclute si ingaggiavano per 10 anni e avevano diritto a rice-