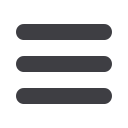

www.
edises
.it
Finalità e struttura dell’opera
Il presente lavoro si pone come strumento di supporto per quanti si apprestano alla prepa-
razione del concorso a cattedra per le classi il cui programma d’esame comprende la Filoso-
fia. Premessa imprescindibile non può che essere una riflessione sull’importanza dell’inse-
gnamento di tale disciplina nella formazione della coscienza e della personalità dei discenti.
Secondo una definizione data da una commissione ministeriale incaricata di affrontare
il problema dell’insegnamento filosofico nelle scuole, la riflessione filosofica si caratte-
rizza «
come forma di metariflessione concettuale, mobile e flessibile, connessa con una considera-
zione critica concernente l’origine, le condizioni, i metodi, i limiti e i valori che contraddistinguono
nella loro effettiva concretezza i vari saperi e le differenti discipline
».
Il compito della Filosofia è, dunque, quello di aprire la mente, abituare i ragazzi al ra-
gionamento, condurli ad individuare i propri limiti, e attraverso ciò le proprie potenzia-
lità. Ma deve essere anche quello di fornire le capacità di affrontare e risolvere problemi
non in base a credenze, e quindi ad atti di fede o a scelte ideologiche o politiche, bensì
attraverso una riflessione razionale, una deliberazione con se stessi che presuppone il
dialogo, la discussione con sé e con gli altri. Come sostiene Giovanni Reale, la Filosofia
ha un primato proprio, nell’ambito della scuola e nel confronto con le altre discipline,
perché “
costruisce il modo di essere uomo pensante, di ragionare
”. I temi affrontati e la me-
todologia stessa della riflessione filosofica costituiscono un’occasione unica nell’intero
percorso scolastico per sviluppare e affinare le proprie capacità analitiche. Le discipline
di carattere scientifico, pur fondamentali per la formazione culturale, fanno infatti co-
noscere la realtà così com’è, ma non danno giudizi di valore, cioè non sono valutative e
quindi non possono orientare la prassi. Le discipline di carattere letterario, invece, pur
affrontando a volte con molta efficacia i problemi di senso, non hanno come proprio
strumento caratteristico l’analisi razionale, la discussione e la ricerca, l’indagine sui pro-
blemi. Solo la filosofia, secondo Reale, riesce a unire questi due aspetti: la capacità da
un lato di affrontare i problemi di senso, problemi di valore su cosa è giusto e cosa no,
cosa è lecito e cosa no, cosa è bene e cosa è male, e dall’altro lato un tipo di approccio
ai problemi con un metodo razionale, cioè non basato semplicemente su credenze.
Ciò detto, è necessario fare i conti con il crescente disinteresse che gli studenti mo-
strano nei confronti delle discipline umanistiche, e filosofiche in particolare; bisogna
interrogarsi sulle sfide didattiche e metodologiche che si pongono dinanzi ai docenti e
riflettere su quali siano le strategie più efficaci attraverso le quali la Filosofia può torna-
re a stabilire un dialogo con le giovani generazioni. Per essere un buon insegnante di
Filosofia, non basta conoscerla, occorre saperla trasmettere motivando e appassionan-
do gli studenti: l’insegnante deve essere in grado di formare criticamente i suoi studenti
senza, tuttavia, plagiarli né condizionarli.
Per utilizzare un’efficace definizione di Fabio Minazzi, il docente “
deve saper scrivere nel
loro animo scomparendo progressivamente dal loro orizzonte (anche da quello affettivo) per trasfor-
marli, progressivamente, in giovani cittadini autonomi e in grado di camminare liberamente per
il mondo secondo i sentieri e le curvature che più preferiranno seguire. In questo contesto il docente
di Filosofia deve essere in grado di mettere in costante tensione critica le differenti acquisizioni co-


















